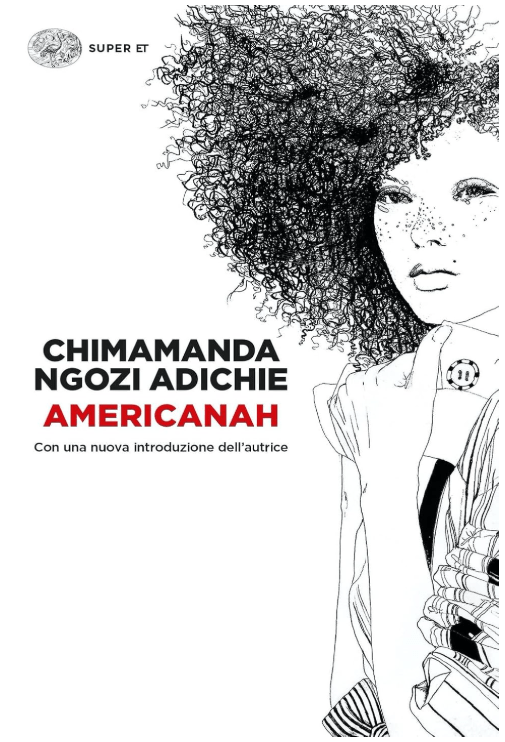Chimamanda Ngozi Adichie
Americanah
EINAUDI, 2024
Romanzo
Impossibile non restare colpiti da Americanah (2013) di Chimamanda Ngozi Adichie, un romanzo letto da Stefano Ratto per Expat Experience Reviews, nell’edizione italiana, edita da Einaudi (2024), con la traduzione di Andrea Sirotti.
Questo romanzo di formazione contemporaneo si presenta come un affresco sociale e intimo, in cui esperienze personali e riflessioni più ampie si intrecciano per offrire uno sguardo penetrante e autentico sulla vita da immigrata/o e sulle sue molteplici sfaccettature. Nata inizialmente come una narrazione delle vicende di Ifemelu e Obinze, il progetto evolve in una profonda esplorazione del tema della ricerca di sé, dell’adattamento culturale e del coraggio necessario per navigare tra mondi diversi.
La storia prende avvio nella Nigeria degli anni Novanta. Conosciamo Ifemelu e Obinze, due giovani innamorati che si confrontano con le incertezze del proprio paese e il desiderio di un futuro migliore. Come molti ragazzi della loro generazione, sognano l’America, terra di opportunità e promesse. Ifemelu, più intraprendente e determinata, parte per gli Stati Uniti con un visto studentesco per frequentare l’Università. Obinze, impossibilitato a raggiungerla, si trasferisce invece a Londra. Questo è il punto in cui il romanzo introduce la profonda tematica dell’espatrio, non solo come mera migrazione geografica, ma come un viaggio di scoperta e ridefinizione dell’identità. Ifemelu e Obinze si ritrovano catapultati in un mondo sconosciuto ad affrontare le sfide dell’adattamento, la solitudine e il peso delle aspettative, sia proprie che altrui.
Agli occhi di un lettore che ha familiarità con l’esperienza dell’espatrio, il percorso di Ifemelu genera un’immediata empatia. Non si tratta solo di comprendere la nostalgia di casa o la difficoltà di ambientarsi, ma piuttosto di riconoscere quel momento cruciale in cui la persona che si era “prima” si dissolve, lasciando spazio a una nuova versione di sé, forgiata dalle prove e dalle opportunità della nuova vita. La sua traversata, sia fisica che emotiva, è un processo di continua autoscoperta. Inizialmente sopraffatta dalle difficoltà economiche e culturali, Ifemelu inizia a esplorare le intricate dinamiche della società americana, in particolare quelle legate alla razza. Lontano dallo sguardo giudicante della sua terra d’origine, sperimenta una nuova forma di libertà, quella di definire sé stessa al di fuori delle etichette preesistenti. Questa libertà si manifesta non solo nella gestione della propria vita, ma anche nella possibilità di dare voce alle proprie osservazioni più acute e talvolta scomode. Attraverso il suo blog, dal nome evocativo “Razzabuglio“, Ifemelu analizza con lucidità e ironia le sfumature del razzismo e dell’identità negli Stati Uniti, diventando una voce autorevole e ammirata. Il successo del suo blog è la dimostrazione che l’impegno e la determinazione possono portare a traguardi inaspettati, anche in un contesto inizialmente ostile.
Diverso il destino di Obinze. Si ritrova a vivere come immigrato clandestino nel Regno Unito, dopo la scadenza del proprio visto. Durante questo periodo, affronta molte difficoltà, tra cui lavori umili e la costante paura di essere scoperto e deportato. Arriva persino a considerare un matrimonio combinato per ottenere un permesso di soggiorno. La comunicazione con chi è rimasto in Nigeria diventa filtrata, spesso edulcorata. Se Ifemelu inizialmente si sforza di non preoccupare la sua famiglia con le difficoltà incontrate, col tempo comprende l’inevitabile appiattimento dei contenuti. Non è facile spiegare le complessità della vita all’estero a chi non le ha vissute. L’autrice nigeriana ci offre uno spaccato dettagliato delle complesse intersezioni di razza, classe e cultura, in un’America che, pur promettendo inclusione, rivela stratificazioni profonde.
Il romanzo presenta un punto di svolta significativo quando Ifemelu decide di fare ritorno in Nigeria. Qui, la situazione è ribaltata. Obinze, arrestato, costretto al rientro e sceso a pesanti compromessi, è riuscito – contro ogni aspettativa – a costruire una carriera di grande successo nel settore immobiliare. È diventato un uomo molto ricco, proprietario di una bella auto e con una grande casa piena di arredi importati. Ifemelu, al contrario, affronta un periodo di riadattamento e disorientamento, poiché il Paese e lei stessa sono cambiati dopo i suoi anni in America. Questo rientro, sebbene somigli a un ritorno alle origini, si rivela un’ulteriore tappa del percorso identitario dei personaggi. La Nigeria, pur familiare, ora appare soprattutto a Ifemelu con gli occhi di chi ha vissuto altrove, con le sue contraddizioni e le sue nuove realtà. Come in ogni esperienza di espatrio, il conflitto di appartenenza emerge con forza: Ifemelu si ritrova in bilico tra le proprie origini e la necessità di mantenere fede alla persona che è diventata, con le sue nuove prospettive e il suo bagaglio di esperienze americane.
Adichie ci consegna una scrittura elegante, incisiva e acuta; dipinge con maestria le sfumature delle culture nigeriana e americana. Al tempo stesso esplora con rara profondità il tema dell’identità individuale di una donna espatriata, mettendo in luce il peso della rottura con la propria comunità e le complesse dinamiche di ritorno e riadattamento. Abbinata alla lettura del romanzo, consiglio la visione di una celebre conferenza dell’autrice all’interno del progetto TED Talks dal titolo Il pericolo di un’unica storia (2009).
Esperienza di lettura: l’identità svelata
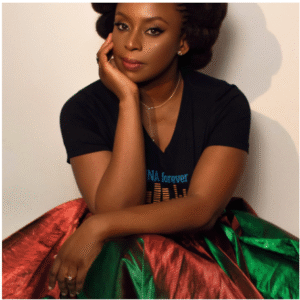 La lettura di “Americanah” lascia con una profonda sensazione di riconfigurazione identitaria. Non è solo la storia di una partenza e di un ritorno (anzi, di due partenze e di due ritorni), ma il resoconto dello strappo che si crea quando si attraversa un confine culturale, e di come, inevitabilmente, si diventi una persona diversa, un “prima” e un “dopo”. La narrazione di Chimamanda Ngozi Adichie è un romanzo di formazione che tocca numerosi tasti sensibili (razzializzazione, privilegio, homecoming); e quanto più ci mostra la libertà e le opportunità che l’integrazione in una nuova realtà può offrire tanto più tratteggia la lacerazione di chi è costantemente in bilico tra due mondi, alle prese ogni giorno con il proprio conflitto di appartenenza e la ridefinizione di cosa significhi essere “a casa”.
La lettura di “Americanah” lascia con una profonda sensazione di riconfigurazione identitaria. Non è solo la storia di una partenza e di un ritorno (anzi, di due partenze e di due ritorni), ma il resoconto dello strappo che si crea quando si attraversa un confine culturale, e di come, inevitabilmente, si diventi una persona diversa, un “prima” e un “dopo”. La narrazione di Chimamanda Ngozi Adichie è un romanzo di formazione che tocca numerosi tasti sensibili (razzializzazione, privilegio, homecoming); e quanto più ci mostra la libertà e le opportunità che l’integrazione in una nuova realtà può offrire tanto più tratteggia la lacerazione di chi è costantemente in bilico tra due mondi, alle prese ogni giorno con il proprio conflitto di appartenenza e la ridefinizione di cosa significhi essere “a casa”.
Recensione di Stefano Ratto, Autore e Docente di Lingua e Letteratura italiana